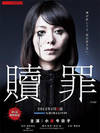oliver twist regia di Roman Polanski Gran Bretagna, Repubblica Ceca, Francia, Italia 2005

al cinemain tvanteprimearchivioserie tvblogtrailerclassifichespecialiregistiattorirecensioniforumfeedmy
oliver twist (2005)
Dove puoi vederlo?

Titolo Originale: OLIVER TWIST
Regia: Roman Polanski
Interpreti: Ben Kingsley, Barney Clark, Lewis Chase, Frances Cuka, Jake Curran, Harry Eden, Frank Finlay, Jamie Foreman, Chris Overton, Leanne Rowe, Mark Strong, Jeremy Swift, Joseph Tremain
Durata: h 2.10Nazionalità: Gran Bretagna, Repubblica Ceca, Francia, Italia 2005
Genere: drammatico
Tratto dal libro "Oliver Twist" di Charles Dickens
Al cinema nell'Ottobre 2005
• Altri film di Roman Polanski
• Link al sito di OLIVER TWIST
Trama del film Oliver twist
Adattamento del classico di Dickens: l'orfanello Oliver fa amicizia, nelle strade di Londra, con un ladruncolo e da questo viene instradato a far parte della famiglia di ladri addestrati dal perfido Fagin.
| Voto Visitatori: |           7,19 / 10 (150 voti) 7,19 / 10 (150 voti) | Grafico |
Voti e commenti su Oliver twist, 150 opinioni inserite









 7 / 10
7 / 102 ore di film non riescono a riportare sulla pellicola la complessità dell’intreccio del romanzo d’origine, che, essendo stato scritto a puntate, è rigorosamente infarcito di colpi di scena, rivolgimenti, cadute, risalite e di nuove ricadute, per giungere poi all’agnizione finale, rivelatrice della parentela tra Oliver e il signor Brownlow che porrà, con abile manovra letteraria, fine al dramma.
La storia del film sembra ricalcare fedelmente soltanto la prima parte del romanzo, tralasciando del tutto l’agnizione conclusiva e le tormentate vicende più strettamente collegate alla famiglia Brownlow e ai personaggi di Rosa e Monks (di cui non viene fatto minimamente cenno). Forse la volontà del regista è stata quella di volersi concentrare sul personaggio più interessante dell’opera, Fagin, l’ebreo ladro che sopravvive di espedienti nei bassifondi londinesi, trovando, nell’arte del furto e nello sfruttamento minorile, un mezzo di sostentamento in una società generatrice di quei “mostri” di cui, poi, essa stessa, prova repellenza e che non esita a condannare, una volta diventati adulti.
E se è la società stessa a generare quei mostri che non ammette di riconoscere come figli suoi, sin dall’inizio del film i buoni borghesi dell’associazione parrocchiale non si fanno scrupoli a ricorrere più volte all’immagine della forca di fronte al fragile Oliver, macchiatosi dell’unica colpa di essere orfano e abbandonato.
Paradossalmente viene da pensare che i luoghi dove si consuma la maggior violenza siano non soltanto i vicoli della Londra più malfamata, ma i luoghi stessi dove si dovrebbe invece ristabilire una certa giustizia, come l’ospizio parrocchaile o la sala del tribunale.
Mentre Dickens si diverte a rappresentare con arguto humor la galleria umana di una classe agiata detentrice del potere, pennellandola con brevi tratti in tutta la sua intima meschinità, ottusità e piccineria, il regista al contrario, sceglie di allontanare ancora di più figure come quella di Bumble o dei giudici, da una parte per rendere l’idea di una giustizia lontana e senza volto, e dall’altra per focalizzarsi meglio sulla figura di Fagin l’ebreo, dal fascino ambiguo e luciferino.
Bastano pochi “colpi di pellicola” per mettere in scena l’ottusità dell’assemblea parrocchiale che scambia l’angelica ingenuità del fanciullo Oliver per stupidità e non risparmia di parlare di forca di fronte al ragazzo, come se questo, ai loro occhi, avesse un destino già segnato in partenza. La comunità del potere, sembra così essere essa stessa l’invisibile orchestratrice del futuro di miseria e balordaggine che porterà molti di quei bambini, accolti nelle loro “workhouse”, verso il destino tragico di futuri malfattori, figli di una società che sembra condannarli già a priori. E l’inquietante riferimento alla forca, che aleggia in tutto il libro e nel film, sembra apppunto inverarsi nel tragico finale, dopo essere stata così a lungo invocata con tanta leggerezza dai detentori di quel potere sommario di cui varie volte Oliver è vittima e da cui non potebbe forse mai liberarsi con le sue uniche forze. Sarà solo la “fortuna” di un incontro, di un’agnizione libresca a riscattare con l’inverosimile quello che normalmente nella vera società vittoriana sarebbe stato destinato al fallimento e alla miseria.
Oliver può salvarsi grazie ad un deus ex machina, ad una sorta di “mano di Dio” che permetterà al fanciullo quella salvezza che sennò non potrebbe mai compiersi per mano della comune giustizia. E l’autore Dickens (seguito a ruota senza tradimenti da Polanski), interviene a ristabilire un ordine che una società ingiusta non riesce a garantire.
Il fatto che Polanski si sia concentrato su Fagin, indiscussa figura principe dal fascino ambiguo, sembra insinuare l’idea che la mancanza di un’intervento da parte del destino romanzesco (come è avvenuto invece per Oliver), possa trasformare teneri bambini in reietti della società, in futuri Fagin, sfruttatori di un’infanzia che ad essi stessi fu un tempo sottratta da quella società che li ha resi tali a causa di tanta indifferenza e incomprensione.
Il perpetuamento di giustizia sommaria ha così come risvolto i tanti Bill Sikes, Nancy o Fagin.
Se il primo personaggio sembra senza speranze indurito, totalmente incattivito dalla vita, Nancy e Fagin sembrano percorsi talvolta, nella loro capacità di provare ANCORA pietà, da estemporanei fremiti di quello che furono un tempo: bambini. E da lì ecco la rappresentazione di un Fagin paradossalmente più “dignitoso” dei tanti Mr Bumble con le loro mazze e i loro ridicoli tricorni, che il regista non esita a rendere marginali, per dare spazio all’ebreo, alla pietà che esso suscita nel momento in cui vi si può scorgere l’immagine di quel bambino che anche esso fu.
Ben Kingsley dà vita alle ambiguità di Fagin, incurvatosi sotto il peso di una vita stentata, dal volto rugoso, sporco, coi denti ingialliti e consunti, apparendo, pur nella sua viscida presenza, immagine portatrice di un dolore di cui si sono ormai perse le antiche origini di probabile ex-vittima, ma di cui ancora si possono scorgere le traccie in quel suo sorriso scivoloso, in quella sua strana “affezione sfruttatrice” verso i suoi ragazzi, capace ancora di una risonanza nel dolore, a diferenza del compagno Sikes vittima ormai oltre che della società anche di se stesso.
Il film, unica pecca, non riesce a restituire a pieno l’intensità della scena finale nelle prigioni che nel libro si caricava della tensione del pubblico processo all’ebreo (ma nel film tagliata), e della successiva disperazione solitaria dell’ultima notte di Fagin, che nel romanzo acquistava una sorta di forza visionaria che nel film non riesce a prender forma, stemperata dalla scena del bimbo che cerca di redimere il vecchio con un’ultima preghiera al cielo. Eppure, cinematograficamente, la notte di Fagin me la sarei immaginata più dilatata, surreale, agitata da fantasmi mentali, lo spazio di solitaria resistenza disperata di un vecchio contro un destino metafisico a cui incosciamente si rivolta.
Il film segue lo svolgersi della storia con una certa freddezza mentre nel libro la forza del romanzesco riusciva a conferire ritmo, e il fiume di pagine a restituire, al susseguirsi serrato degli eventi, momenti di calma e d’analisi dei personaggi. Il rischio di riportare su pellicola romanzi così densi di eventi rischia sempre di far prevalere lo sforzo della ricostruzione storica e dei fatti sulle sfumature, sulle descrizioni psicologiche ecc.
L’intelligenza del regista è stata quella di essersi concentrato solo su una parte della storia e sul rapporto tra società e i suoi frutti, sul rapporto tra potenza e atto, tra un Oliver, bambino di strada salvato da un incontro risolutivo (NON più agnizione nel film) e Fagin, altro “bambino” di strada non redento dalla mano di alcun Dio-autore, vittima e assieme incarnazione di una società fatta di giustizia sbrigativa e istutuzioni dal volto disumano.
La pellicola riesce a restituire allo spettatore l’immaginario di una londra industriale, di una città sporca, viziosa, senza dare molto spazio alla dimensione più “borghese” del romanzo, (Bronwlow è appena una comparsa, ed è del tutto assente il personaggio di Rosa) volutamente tralasciata perché inutile all’inquietante rappresentazione di una società, apparentemente perbenista e pulita come quella vittoriana, ma dai risvolti tragici incarnati dalla grande figura dell’ebreo Fagin- Kingsley.
La storia del film sembra ricalcare fedelmente soltanto la prima parte del romanzo, tralasciando del tutto l’agnizione conclusiva e le tormentate vicende più strettamente collegate alla famiglia Brownlow e ai personaggi di Rosa e Monks (di cui non viene fatto minimamente cenno). Forse la volontà del regista è stata quella di volersi concentrare sul personaggio più interessante dell’opera, Fagin, l’ebreo ladro che sopravvive di espedienti nei bassifondi londinesi, trovando, nell’arte del furto e nello sfruttamento minorile, un mezzo di sostentamento in una società generatrice di quei “mostri” di cui, poi, essa stessa, prova repellenza e che non esita a condannare, una volta diventati adulti.
E se è la società stessa a generare quei mostri che non ammette di riconoscere come figli suoi, sin dall’inizio del film i buoni borghesi dell’associazione parrocchiale non si fanno scrupoli a ricorrere più volte all’immagine della forca di fronte al fragile Oliver, macchiatosi dell’unica colpa di essere orfano e abbandonato.
Paradossalmente viene da pensare che i luoghi dove si consuma la maggior violenza siano non soltanto i vicoli della Londra più malfamata, ma i luoghi stessi dove si dovrebbe invece ristabilire una certa giustizia, come l’ospizio parrocchaile o la sala del tribunale.
Mentre Dickens si diverte a rappresentare con arguto humor la galleria umana di una classe agiata detentrice del potere, pennellandola con brevi tratti in tutta la sua intima meschinità, ottusità e piccineria, il regista al contrario, sceglie di allontanare ancora di più figure come quella di Bumble o dei giudici, da una parte per rendere l’idea di una giustizia lontana e senza volto, e dall’altra per focalizzarsi meglio sulla figura di Fagin l’ebreo, dal fascino ambiguo e luciferino.
Bastano pochi “colpi di pellicola” per mettere in scena l’ottusità dell’assemblea parrocchiale che scambia l’angelica ingenuità del fanciullo Oliver per stupidità e non risparmia di parlare di forca di fronte al ragazzo, come se questo, ai loro occhi, avesse un destino già segnato in partenza. La comunità del potere, sembra così essere essa stessa l’invisibile orchestratrice del futuro di miseria e balordaggine che porterà molti di quei bambini, accolti nelle loro “workhouse”, verso il destino tragico di futuri malfattori, figli di una società che sembra condannarli già a priori. E l’inquietante riferimento alla forca, che aleggia in tutto il libro e nel film, sembra apppunto inverarsi nel tragico finale, dopo essere stata così a lungo invocata con tanta leggerezza dai detentori di quel potere sommario di cui varie volte Oliver è vittima e da cui non potebbe forse mai liberarsi con le sue uniche forze. Sarà solo la “fortuna” di un incontro, di un’agnizione libresca a riscattare con l’inverosimile quello che normalmente nella vera società vittoriana sarebbe stato destinato al fallimento e alla miseria.
Oliver può salvarsi grazie ad un deus ex machina, ad una sorta di “mano di Dio” che permetterà al fanciullo quella salvezza che sennò non potrebbe mai compiersi per mano della comune giustizia. E l’autore Dickens (seguito a ruota senza tradimenti da Polanski), interviene a ristabilire un ordine che una società ingiusta non riesce a garantire.
Il fatto che Polanski si sia concentrato su Fagin, indiscussa figura principe dal fascino ambiguo, sembra insinuare l’idea che la mancanza di un’intervento da parte del destino romanzesco (come è avvenuto invece per Oliver), possa trasformare teneri bambini in reietti della società, in futuri Fagin, sfruttatori di un’infanzia che ad essi stessi fu un tempo sottratta da quella società che li ha resi tali a causa di tanta indifferenza e incomprensione.
Il perpetuamento di giustizia sommaria ha così come risvolto i tanti Bill Sikes, Nancy o Fagin.
Se il primo personaggio sembra senza speranze indurito, totalmente incattivito dalla vita, Nancy e Fagin sembrano percorsi talvolta, nella loro capacità di provare ANCORA pietà, da estemporanei fremiti di quello che furono un tempo: bambini. E da lì ecco la rappresentazione di un Fagin paradossalmente più “dignitoso” dei tanti Mr Bumble con le loro mazze e i loro ridicoli tricorni, che il regista non esita a rendere marginali, per dare spazio all’ebreo, alla pietà che esso suscita nel momento in cui vi si può scorgere l’immagine di quel bambino che anche esso fu.
Ben Kingsley dà vita alle ambiguità di Fagin, incurvatosi sotto il peso di una vita stentata, dal volto rugoso, sporco, coi denti ingialliti e consunti, apparendo, pur nella sua viscida presenza, immagine portatrice di un dolore di cui si sono ormai perse le antiche origini di probabile ex-vittima, ma di cui ancora si possono scorgere le traccie in quel suo sorriso scivoloso, in quella sua strana “affezione sfruttatrice” verso i suoi ragazzi, capace ancora di una risonanza nel dolore, a diferenza del compagno Sikes vittima ormai oltre che della società anche di se stesso.
Il film, unica pecca, non riesce a restituire a pieno l’intensità della scena finale nelle prigioni che nel libro si caricava della tensione del pubblico processo all’ebreo (ma nel film tagliata), e della successiva disperazione solitaria dell’ultima notte di Fagin, che nel romanzo acquistava una sorta di forza visionaria che nel film non riesce a prender forma, stemperata dalla scena del bimbo che cerca di redimere il vecchio con un’ultima preghiera al cielo. Eppure, cinematograficamente, la notte di Fagin me la sarei immaginata più dilatata, surreale, agitata da fantasmi mentali, lo spazio di solitaria resistenza disperata di un vecchio contro un destino metafisico a cui incosciamente si rivolta.
Il film segue lo svolgersi della storia con una certa freddezza mentre nel libro la forza del romanzesco riusciva a conferire ritmo, e il fiume di pagine a restituire, al susseguirsi serrato degli eventi, momenti di calma e d’analisi dei personaggi. Il rischio di riportare su pellicola romanzi così densi di eventi rischia sempre di far prevalere lo sforzo della ricostruzione storica e dei fatti sulle sfumature, sulle descrizioni psicologiche ecc.
L’intelligenza del regista è stata quella di essersi concentrato solo su una parte della storia e sul rapporto tra società e i suoi frutti, sul rapporto tra potenza e atto, tra un Oliver, bambino di strada salvato da un incontro risolutivo (NON più agnizione nel film) e Fagin, altro “bambino” di strada non redento dalla mano di alcun Dio-autore, vittima e assieme incarnazione di una società fatta di giustizia sbrigativa e istutuzioni dal volto disumano.
La pellicola riesce a restituire allo spettatore l’immaginario di una londra industriale, di una città sporca, viziosa, senza dare molto spazio alla dimensione più “borghese” del romanzo, (Bronwlow è appena una comparsa, ed è del tutto assente il personaggio di Rosa) volutamente tralasciata perché inutile all’inquietante rappresentazione di una società, apparentemente perbenista e pulita come quella vittoriana, ma dai risvolti tragici incarnati dalla grande figura dell’ebreo Fagin- Kingsley.
In programmazione
Ordine elenco: Data Media voti Commenti Alfabetico
NEW
"cime tempestose" (2026)2 cuori e 2 capanne2000 metri ad andriivka28 anni dopo: il tempio delle ossaagata christian - delitto sulle nevianaconda (2026)articolo 1avatar - fuoco e cenereben - rabbia animalebuen caminoconan, il ragazzo del futuro NEW
crime 101 - la strada del criminedivine comedy NEW
due procuratorielena del ghettoellie e la citta' di smeraldofather mother sister brotherfilmlovers!franco battiato - il lungo viaggiofratelli demolitorigioia miagiulio regeni - tutto il male del mondo NEW
goat - sogna in grandegreenland 2: migrationhambrehamnet - nel nome del figlioil dono piu' preziosoil falsario NEW
il mago del cremlino - le origini di putinil profeta (2025)in the hand of danteio+tekraken NEW
la gioiala graziala mia famiglia a taipeila piccola ameliela scelta di josephla scomparsa di josef mengelela stanza di marianala villa portoghese R
la voce di hind rajabl'agente segreto (2026)lavoreremo da grandile cose non detteleopardi & col'infiltratalo sconosciuto del grande arcol'ombra del corvolupin the iiird: the movie - la stirpe immortalemarty suprememelaniamemoria di una rivoltamercy: sotto accusa NEW
mio fratello e' un vichingomonsieur aznavourmy father's shadowno other choice - non c'e' altra sceltanorimberganorth - la regina delle nevi NEW
per un po' NEW
pillion - amore senza frenipolvo seran - polvere di stelleprendiamoci una pausaprimavera (2025)return to silent hillsend helpsentimental valuesiratsong sung blue - una melodia d'amoresorry, babyspongebob - un'avventura da piratistray kids: the dominate experience NEW
the long walk - se ti fermi muorithe rip - soldi sporchithe teacher (2023)tienimi presentetony, shelly e la luce magicaultimo schiaffoun inverno in coreaun topolino sotto l'alberouna di famigliavita privata (2025)wider than the sky - piu' grande del cielo1069297 commenti su 53137 film
Ultimi film inseriti in archivio
A SERBIAN DOCUMENTARYBEYOND UTOPIACARLOS ALCARAZ: A MODO MIOCHRISTYDRACULA (2025)REMEMBER TO BLINKRICK AND MORTY - STAGIONE 8THE DUTCHMANTHE HOME - IL SEGRETO DEL QUARTO PIANOTHE PLAGUE (2025)TI CERCOWE BURY THE DEADWHITE LIGHT/BLACK RAIN - THE DESTRUCTION OF HIROSHIMA AND NAGASAKI
Ultimo film commentato
Ultimo post blog
OSCAR 2018
3/6/2018 10:08:03 AM - Kater
Si č celebrata il 4 marzo 2018 la 90° edizione della Cerimonia degli Oscar, al Dolby Theatre di Los Angeles. Ecco l'elenco completo degli Oscar 2018, con i relativi vincitori (in grassetto). MIGLIOR FILM La forma dell'acqua - The shape of water - Guillermo del Toro e J. Miles Dale Chiamami col t...
3/6/2018 10:08:03 AM - Kater
Si č celebrata il 4 marzo 2018 la 90° edizione della Cerimonia degli Oscar, al Dolby Theatre di Los Angeles. Ecco l'elenco completo degli Oscar 2018, con i relativi vincitori (in grassetto). MIGLIOR FILM La forma dell'acqua - The shape of water - Guillermo del Toro e J. Miles Dale Chiamami col t...
Speciali
Ultime recensioni inserite
in sala
IL MAESTRO (2025)
 Regia: Andrea Di Stefano
Regia: Andrea Di StefanoInterpreti: Pierfrancesco Favino, Tiziano Menichelli, Giovanni Ludeno, Dora Romano, Paolo Briguglia, Valentina Bellč, Edwige Fenech
Genere: commedia
Recensione a cura di The Gaunt
A HOUSE OF DYNAMITE
 Regia: Kathryn Bigelow
Regia: Kathryn BigelowInterpreti: Idris Elba, Rebecca Ferguson, Gabriel Basso, Jared Harris, Tracy Letts, Anthony Ramos, Moses Ingram, Jonah Hauer-King, Greta Lee, Jason Clarke
Genere: thriller
Recensione a cura di The Gaunt
archivio
SEPTEMBER 5 - LA DIRETTA CHE CAMBIO' LA STORIA
 Regia: Tim Fehlbaum
Regia: Tim FehlbaumInterpreti: John Magaro, Leonie Benesch, Peter Sarsgaard, Ben Chaplin, Zinedine Soualem, Georgina Rich, Corey Johnson, Marcus Rutherford, Daniel Adeosun, Benjamin Walker, Ferdinand Dörfler, Solomon Mousley, Caroline Ebner, Daniel Betts, Leif Eduard Eisenberg, Sebastian Jehkul, Rony Herman, Jeff Book, Robert Porter Templeton, Stephen Fraser, Leon Dragoi, Doris Meier, Mark Ruppel, Christine Ulrich, Günther Wernhard, Antje Westermann, Harry Waterstone, Andreas Honold, Stefan Mittermaier
Genere: drammatico
Recensione a cura di The Gaunt
NOSFERATU (2024)
 Regia: Robert Eggers
Regia: Robert EggersInterpreti: Lily-Rose Depp, Nicholas Hoult, Bill Skarsgĺrd, Aaron Taylor-Johnson, Willem Dafoe, Emma Corrin, Ralph Ineson, Simon McBurney, Adéla Hesová, Milena Konstantinova, Stacy Thunes, Gregory Gudgeon, Robert Russell, Curtis Matthew, Claudiu Trandafir, Georgina Bereghianu, Jordan Haj, Kateřina Bílá, Maria Ion, Tereza Dušková, Liana Navrot, Mihai Verbintschi, Karel Dobrý, Andrei Sergeev, Matěj Beneš, Marek Pospíchal, Jan Filipenský, Alex East, Christian Dunckley Clark
Genere: horror
Recensione a cura di Harpo
Ultima biografia inserita
Casualmente dall'archivio
Novità e Recensioni
Iscriviti alla newsletter di Filmscoop.it per essere sempre aggiornarto su nuove uscite, novità, classifiche direttamente nella tua email!






 Il paesaggio rurale di questo film sembra una tavola pittorica per come riesce ad ammaliare e rassicurare. Ma appena si approfondisce il contesto e si entra nella tavolozza si vede chiaramente la disfunzionalità di un nucleo familiare e bambini vittime di criminali pedofili. Mantenendo sempre i...
Il paesaggio rurale di questo film sembra una tavola pittorica per come riesce ad ammaliare e rassicurare. Ma appena si approfondisce il contesto e si entra nella tavolozza si vede chiaramente la disfunzionalità di un nucleo familiare e bambini vittime di criminali pedofili. Mantenendo sempre i...